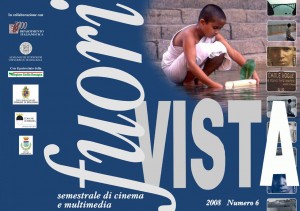di Pasquale Misuraca (giugno e luglio e agosto 2011)
Lunedì 4 luglio 2011
Mi trovo a Castel di Sangro, un paese montano in provincia de L’Aquila. Mattina. Maestri di sport e giovani sportivi. Si allenano, si parlano. Commovente. Pomeriggio. Leggo la Repubblica. Uno, due, tre articoli delle prime e seconde e terze pagine, leggo e non posso non pensare a Pasolini. Pasolini inutile.
Gli articoli infatti parlano di ‘politica’ (italiana) raccontando e analizzando niente altro che il ‘Palazzo’. Sì, la politica (in Italia) è ridotta, su tutti i mezzi di comunicazione di massa, giornali, radio, televisioni, e persino sui mezzi di comunicazione reticolare, blog, siti, social network, alle gesta e alle opinioni degli uomini dei partiti, delle istituzioni, delle burocrazie, delle corporazioni: il ‘Palazzo’. Sento risuonare dentro di me le inutili osservazioni pasoliniane del 1975 – cito a memoria, trascrivendo con la penna sul giornale: Soltanto ciò che succede dentro il ‘Palazzo’ è considerato degno di interesse. Il resto è minutaglia, brulichio, informità.
Chiudo il giornale, il pessimismo dell’intelligenza, lo riapro, l’ottimismo della volontà. E m’imbatto in un’intervista di Simonetta Fiori a Goffredo Fofi, “fondatore di riviste e di progetti” lo definisce il redattore. Lascia stare Pasolini, mi dico, e leggi cosa pensa oggi dell’Italia e del mondo questo intellettuale non stupido, hai letto due o tre suoi buoni libri di cinema, leggi e apri le orecchie.
Ma Simonetta ha la cattiva idea di interrogarlo su Pasolini. Domanda: “Lei è molto critico con Pasolini, accusato di idealizzare la povertà.” Risposta: “Pasolini enfatizzava l’Italia arcaica, ma sbagliava. Anni fa portai a Gubbio una coppia di intellettuali milanesi. C’era ancora mia madre, appena tornata dalla Francia dove i miei genitori erano emigrati: lei faceva la stiratrice, mio padre il gruista. I giovani amici le chiedevano entusiasti di evocare un passato incontaminato, lei felice li assecondava, quando all’improvviso s’incupì: ‘Oh ragazzi, io dirò sempre una preghiera per quello che s’è inventato il cesso dentro casa’“
Trentasei anni sono trascorsi dalla morte di Pasolini, e un italiano intelligente dice ancora questa stupidaggine – condivisa del resto da tanti intellettuali. I quali leggono e rileggono Pasolini senza resistere alla tentazione di ricondurlo, cioè di ridurlo, ai propri interessi, alle proprie ideologie, alle proprie speranze, ai fantasmi della propria gioventù, alle battute della propria mamma.
Sabato 9 luglio 2011
Di ritorno a Roma, ritrovo il testo dell’intervento che ho svolto il 2 novembre 2005, alla Triennale di Milano – nell’occasione del trentennale della morte violenta di Pasolini. Ne trascrivo parte della parte relativa a Pasolini – in quella ‘charla’ collegavo la sua figura e la sua opera alle opere e alle figure di Gramsci e Gesù.
“…Pasolini degli Scritti Corsari, delle Lettere Luterane, dell’‘Ultima Intervista’ registrata da Furio Colombo poche ore prima della sua venuta a morte.
Cosa ha pensato e detto Pasolini della ‘crisi’, che smascherava i potenti (rendendoli ridicoli) e
omologava i giovani (rendendoli infelici)? Pensava e diceva che era in corso ‘una nuova grande rivoluzione passiva’, il cui centro motore era il ‘Nuovo Potere Reale’ e gli effetti concreti ‘una grande mutazione antropologica’, insomma che quella sua, che questa nostra, non era, non è una crisi congiunturale, bensì è una ‘crisi organica’ (Antonio Gramsci, ‘Quaderni del carcere’).
Ora, allora, come hanno reagito i suoi ‘amici’, al suo pensiero teorico e alla sua rappresentazione ideologica? In vita dicendo che Pasolini esagerava drammaticamente il presente e rimpiangeva nostalgicamente il passato. E in morte ripetendo infinite volte e in tutte le salse che alla base della sua morte c’era un ‘complotto’ – un complotto che aveva come mandante ideologico la borghesia e come esecutori materiali i fascisti. A parole cioè i suoi ‘amici’ riconoscevano in Pasolini un fratello-maestro, nei fatti disconoscevano il suo pensiero teorico e la sua rappresentazione ideologica.
Infatti Pasolini aveva scritto chiaro e tondo che nell’Italia degli anni Settanta vivevano e vagavano ‘giovani infelici’ non più fascisti, non più comunisti, immersi come erano in un ‘vuoto culturale’, i quali potevano uccidere e uccidevano ‘senza mandanti e senza scopo’, e aveva conseguentemente detto fino alla fine, fin nell’intervista a Furio Colombo, che l’idea del ‘complotto borghese e fascista’ è delirante, facile, semplice, consolatoria. Leggo: ‘Soprattutto il complotto ci fa delirare. Ci libera da tutto il peso di confrontarci da soli con la verità. Che bello se mentre siamo qui a parlare qualcuno in cantina sta facendo i piani per farci fuori. E’ facile, è semplice…”
Martedì 12 luglio 2011
Viaggio in Sicilia. Bagheria, infiorata, inondata, soffocata, da misteriosi convolvoli, è un inferno. A malapena riesco a posteggiare. Così tutte le coste, da Punta Raisi verso est. Il mare s’intravvede a stento. “Cosa hanno da gridare questi giovani? Noi abbiamo visto il mare. Loro non lo vedranno più.” – recito rivolto ad Alexandra, la mia complice, citando Pasolini – lei sa di cosa parlo. Fuggiamo verso il Parco delle Madonie: le montagne ancora si vedono in Sicilia.
Sto di fronte alla rocca di Geraci Siculo, tiro fuori un libro che mi sono portato dietro per il viaggio e leggo, rileggo, si tratta di Pier Paolo Pasolini, Scritti corsari, Garzanti 1975: forse sono io che ho capito male Pasolini, mi dico: era un nostalgico del bel tempo che fu e non me ne sono accorto (mentre realizzavo in trenta anni di lavoro intellettuale un programma televisivo, due documentari, un cortometraggio, un film, e scrivevo un articolo, un saggio, un progetto di documentario, e non mi ricordo più cosa, a partire dalla ‘realtà effettuale’ – Machiavelli – del mondo come intravista nella sua opera):
“8 luglio 1974.
Caro Calvino,
Maurizio Ferrara dice che io rimpiango un’<età dell’oro>, tu dici che rimpiango l’ <Italietta>: tutti dicono che rimpiango qualcosa, facendo di questo rimpianto un valore negativo e quindi un facile bersaglio… Ciò che io rimpiango (se si può parlare di rimpianto)… è il mondo contadino, il mondo sottoproletario, il mondo operaio, il mondo pre-borghese.
Che io rimpianga o non rimpianga questo universo contadino, resta comunque affar mio. Ciò non mi impedisce affatto di esercitare sul mondo attuale così com’è la mia critica: anzi, tanto più lucidamente quanto più ne sono staccato, e quanto più accetto solo stoicamente di viverci.
26 luglio 1974
Io vivo nelle cose, e invento come posso il modo di nominarle. Certo se io cerco di <descrivere> l’aspetto terribile di un’intera nuova generazione, che ha subìto tutti gli squilibri dovuti a uno sviluppo stupido e atroce, e cerco di <descriverlo> in <questo> giovane, in <questo> operaio, non sono capito: perché al sociologo e al politico di professione non importa personalmente nulla di <questo> giovane, di <questo> operaio. Invece a me personalmente è la sola cosa che importa.
Martedì 19 luglio 2011
Di nuovo a Roma. Sotto i pini del Parco di Colle Oppio leggo un libro di Ryszard Kapuściński, Lapidarium, e latolineo questo suo appunto: “Czesław Miłosz: ‘Non è forse una caratteristica di tutti gli intellettuali di questo secolo la fuga dal singolare al plurale?’ (Rok myśliwego, 1991)”
Lo collego mentalmente a quel brano di Pasolini: “…se io cerco di <descrivere> l’aspetto terribile di un’intera nuova generazione, che ha subìto tutti gli squilibri dovuti a uno sviluppo stupido e atroce, e cerco di <descriverlo> in <questo> giovane, in <questo> operaio, non sono capito: perché al sociologo e al politico di professione non importa personalmente nulla di <questo> giovane, di <questo> operaio…”
Mercoledì 20 luglio 2011
La questione del ‘rimpianto’ di Pasolini per un mondo pre-borghese mi gira ancora in testa. Tendenza alla ruminazione e al perfezionismo. Ma ‘rimpianto’ esattamente di cosa? Non della povertà. Rimpianto dell’autonomia culturale dei gruppi sociali subalterni. (Gramsci) Oggi omologate. (Pasolini)
Come? Che c’entra Gramsci con Pasolini? Sto a casa, apro i ‘Quaderni’, rileggo e trascrivo: “Lo Stato antico e quello medioevale era, in un certo senso, un blocco meccanico di gruppi sociali e spesso di razze diverse… i gruppi subalterni avevano una vita, a sé, istituzioni proprie ecc. e talvolta queste istituzioni avevano funzioni statali, che facevano dello Stato una federazione di gruppi sociali con funzioni diverse non subordinate… Lo Stato moderno sostituisce al blocco meccanico dei gruppi sociali una loro subordinazione all’egemonia del gruppo dirigente e dominante… Le dittature contemporanee aboliscono legalmente anche queste nuove forme di autonomia e si sforzano di incorporarle nell’attività statale: l’accentramento legale di tutta la vita nazionale nelle mani del gruppo dominante diventa ‘totalitario’. (Quaderno 25, Ai margini della storia – Storia dei gruppi sociali subalterni.)
Pasolini vede accadere negli anni Settanta in Italia ciò che accade nella civiltà moderna dalla fine della civiltà medioevale all’inizio del Novecento, quando entra in crisi organica la civiltà moderna. Gramsci questo ‘vede’ nei Quaderni, e su questa visione scientifica fonda la scienza della storia e della politica.
Giovedì 21 luglio 2011
Mi trovo a Centocelle, un quartiere popolare di Roma. Ha le case basse, si deve il cielo a Centocelle, agrumi e paltas nei cortili, popolani e immigrati per le strade. Mi sono portato dietro le Lettere luterane. All’ombra di un platano, aspettando il mio turno all’ufficio della circoscrizione, ritrovo il testo ‘I giovani infelici’, che si apre con queste parole: “Uno dei temi più misteriosi del teatro tragico greco è la predestinazione dei figli a pagare le colpe dei padri. Non importa se i figli sono buoni, innocenti, pii: se i loro padri hanno peccato, essi devono essere puniti.” e si chiude con
queste parole: “In altre parole la nostra colpa di padri consisterebbe in questo: nel credere che la storia non sia e non possa essere che la storia borghese.”
Lo traduco nel linguaggio della scienza della storia e della politica: viviamo una crisi di civiltà ma non lo sappiamo. Noi padri. E questo lo pagano i nostri figli. I giovani, che per questo, per questa nostra colpevole ignoranza, vivono infelicemente.
Mi guardo intorno e vedo ciò che leggo in Pasolini grande descrittore della fase terminale della crisi organica: “I figli che ci circondano, specialmente i più giovani, gli adolescenti, sono quasi tutti dei mostri. Il loro aspetto fisico è quasi terrorizzante, e quando non terrorizzante, è fastidiosamente infelice. Orribili pelami, capigliature caricaturali, carnagioni pallide, occhi spenti. Sono maschere di qualche iniziazione barbarica. Oppure, sono maschere di una integrazione diligente e incosciente, che non fa pietà. Il loro pensiero è perpetuamente altrove. Nei casi peggiori sono dei veri e propri criminali. Quanti sono questi criminali? In realtà, potrebbero esserlo quasi tutti.”
Da quattro di questi giovani infelici Pier Paolo Pasolini è stato ucciso, nella notte tra l’uno e il due novembre 1975.
Ma vedo anche, intorno, a Centocelle, giovani felici, in quantità. Non c’erano al tempo delle Lettere luterane? O Pasolini non sapeva vederli?
Venerdì 22 luglio 2011
Chi leggerà questa nota su questa rivista? Vorrei essere letto da Gennariello, ecco da chi, l’idealtipo sociologico definito da Pasolini, un adolescente che frequenta le ultime classi dell’obbligo, “se non un miracolo, certo un’eccezione, questo sì” (Lettere luterane, Sezione prima: Gennariello – Paragrafo primo: come ti immagino).
E vorrei essere letto da quegli adolescenti (ora diventati adulti, e quasi miei coetanei) che ho visto con questi occhi e ascoltato con questi orecchi nel settembre del 1972, ero giovane allora e avevo 24 anni, ed ero andato alla Libreria Ferro di Cavallo, a via Ripetta di Roma, alla presentazione del libro di Pier Paolo Pasolini Empirismo eretico, per vederlo discutere con gli intellettuali, gli scienziati, i politici, i letterati che lo contrastavano, che lo irridevano, ma quelli non c’erano, erano nei propri salotti – allora pensai: erano “sui gradini del Palazzo” (Roberto Rossellini) – ho pensato qualche anno dopo. C’erano una ventina di adolescenti felici e infelici, si sono seduti a terra, in circolo, con Pier Pasolini adolescente tra gli adolescenti, ed erano più le domande che lui faceva loro che loro a lui.
Sabato 23 luglio 2011
Paola, in provincia di Cosenza. ‘Paola in jazz.’ Maestri e Allievi, Vecchi e Giovani, Padri e Figli – in armonia. Il decentramento pienamente riuscito. Giovani felici, in quantità. Concerto di chiusura. Chissà cosa ne avrebbe pensato Pasolini.
Martedì 2 agosto 2011
Navigando nel Gruppo Facebook AMICI DI PASOLINI, vengo a conoscenza di un video che non conoscevo: http://www.youtube.com/watch?v=uKnwddtANK0
Si tratta di una intervista audio-video registrata (apparentemente) sul set di Salò. L’intervistatore domanda: “In che modo la lezione di questo film potrebbe essere capita dai giovani che ci circondano?” E Pasolini risponde: “Mah, io credo che i giovani non lo capiranno. Non mi illudo di essere capito dai giovani, perché coi giovani è impossibile instaurare un rapporto di carattere culturale, perché i giovani vivono nuovi valori, con cui i miei vecchi valori in nome dei quali io parlo sono incommensurabili. Tutti i miei libri e tutte le mie opere narrative parlano di giovani, li amavo e li rappresentavo, adesso non potrei fare un film su questi imbecilli che ci circondano… Questa nuova generazione di giovani, odiosa, nella massa, perché poi c’è un’infinità di eccezioni, ancora, abbastanza…”
Venerdì 5 agosto 2011
Sto a Genova, a trovare Giuliano Cabrini, un amico di lunga data. È caduto, si è rotto la testa, è in ospedale, si sta riprendendo. Gli dico che sto scrivendo un ‘intervento’ su Pasolini. Si illumina in volto. Mi viene in mente l’incipit di un suo racconto, poi, attraverso il computer, nel sito-rivista del quale siamo coautori, ritrovo il brano preciso: “Chi può amare un riccio? Si può amare un cane che si lascia accarezzare il pelo morbido mentre lecca la tua mano, si può amare un gatto che fa le fusa e si struscia alla tua gamba, si può persino amare un topo che sale sul braccio per arrivare al tuo viso e appoggiare la sua testa sul collo. Ma chi può amare un riccio?”
Pasolini era un riccio.
Sabato 6 agosto 2011
Ancora a Genova, leggo su la Repubblica.it la settima tappa dell’inchiesta di Paolo Rumiz, ‘Le case degli spiriti’. Questa volta va ad Africo, paese d’Aspromonte. Ma prima di andarci ascolta due suoi passati abitanti, che ora vivono, vecchi, a Bova Marina.
“La memoria di Africo era scesa a valle, e a Bova Marina si incarnò in un’anziana tabaccaia che dormicchiava su una poltrona presso il bancone. Angela Bruzzaniti si chiamava, e il figlio Pasquale, che badava ai clienti, la scosse dal torpore spiegando che uno del Nord era sceso fin lì per sentire le storie del paese. Angela si stropicciò gli occhi, sorrise, disse: “Era bello lassù. C’era musica e ballo. Nella banda suonavo l’armonium. Eravamo poveri e allegri”.
Sul retro dormicchiava in poltrona anche il marito di lei, Domenico, anni 94. Africo per lui era altra cosa: miseria, burroni, alluvioni, vita “allo stato primitivo come bestie”. “Si mangiava pane e lenticchie, qualche fico, castagne. Il prete faceva anche da medico, ti dava gli infusi e poi i sacramenti”. C’era da chiedersi se lui e la moglie avessero visto lo stesso luogo.”
Mi chiedo se Fofi (e Calvino eccetera) e Pasolini abbiano visto lo stesso luogo, la stessa Italia, lo stesso mondo.
Lunedì 15 agosto 2011
Roma. Ferragosto. Mattina presto. Passano gli anni e mi sveglio sempre più presto. Lavoricchio tre ore e schizzo fuori casa per mettermi il cielo sulla testa, uscendo pesco un libretto rosso nella libreria dell’atrio, è Dialogo con Pasolini. Scritti 1957 – 1984, raccoglie tutti gli scritti di Pasolini e “un’ampia scelta degli articoli sullo scrittore e sulla sua opera” (nota ai testi di Alberto Cadioli) usciti su ‘Rinascita’ (“mensile politico-culturale del Partito Comunista Italiano fondato da Palmiro Togliatti nel 1944” – Wikipedia)
Veramente, avevo deciso di non leggere più niente di Pasolini e su Pasolini, fino agli ultimi giorni di agosto, quando sarebbe venuto il tempo di rileggere il già pensato e scritto, apportarvi qualche minuscola correzione formale.
Ma non ho resistito al titolo del libro. Dialogo con Pasolini. Su ‘Rinascita’. Dialogo dei compagni del Pci con Pasolini. Dialogo? Hanno dialogato, i compagni del Pci, con Pasolini? La domanda che mi faccio riporta il mio pensiero all’appunto su Fofi intellettuale di partito e Pasolini, e decido di riconsiderare ancora una volta, con i testi sottomano, i dialoghi degli intellettuali di partito con Pasolini.
Scelgo una panchina di legno e ferro sotto un cedro del Libano di Villa Celimontana, e leggo, rileggo. La maggior parte degli articoli li ho letti quando ho acquistato il libro, con il mensile, come suo “inserto redazionale allegato al n. 42 del 9.XI.1985”. Arrivo, verso la fine, ad ‘Americanismo e disperazione,’ “il lungo articolo di [Fabio] Mussi [che] uscì, con lo stesso titolo qui proposto, sul n. 26 (28 giugno), 1974, pp. 17-18, come intervento nella polemica nata dall’articolo di Pasolini ‘Gli italiani non sono più quelli’, apparso sul Corriere della Sera del 10 giugno 1974”. Mi rileggo pure questo, pensando che ora, oggi, 2011, Mussi è un due di coppe della cultura ‘di sinistra’, ma allora, nel 1974, era un cavallo di coppe, e galoppava, grazie anche ad articoli come questo: “nel 1979 entra nel Comitato Centrale del PCI: per permettere il suo inserimento, venne abbassata di 3 anni l’età minima per entrare nel Comitato Centrale del PCI. Nello stesso anno è nominato responsabile delle pagine culturali; vice-direttore di Rinascita; vice-responsabile della sezione stampa e propaganda e in ottobre responsabile del settore.” (Wikipedia)
Mussi prima sfoggia la sua preparazione culturale, cita Ferrara e Calvino e Colletti e Fortini e Sciascia, addirittura Gramsci, e poi la sua determinazione dirigenziale: bacchetta Pasolini, perché “si è lasciato sfuggire l’intelligenza dei fatti nuovi avvenuti nel corso degli anni sessanta, a cominciare dal rapporto nuovo che si è andato (con tanta fatica, è vero [sic]) ricostruendo tra intellettuali e popolo, e tra le nuove generazioni e il movimento operaio, il suo programma e la sua memoria storica”.
Sfoggia, bacchetta, irride: “la passione [di Pasolini] per la tematica degli ‘esclusi’ e degli ‘anormali’, così cara al decadentismo europeo [e la] nostalgia [di Pasolini] di neorealismo, di facce segnate dalla fatica e dall’ignoranza che gli paiono fotogeniche, e che non trova più nei giovani meglio nutriti e meglio vestiti di questa società mutata.”
Mi vengono le lacrime agli occhi quando penso alla data. 1974. Stava per uscire l’edizione critica dei Quaderni del carcere di Gramsci. E i compagni del Pci si preparavano a non capirla, e si preparavano a non capirla non capendo Pasolini. Pasolini scrive negli anni settanta del Novecento di una crisi storica, e Gramsci scrive negli anni Trenta del Novecento di una crisi organica, scrivono della stessa cosa, la crisi di civiltà vista da Gramsci alla fine del suo inizio e da Pasolini vista all’inizio della sua fine. Ma i compagni del PCI hanno la storia in tasca e non prendono lezioni da nessuno. Uscirà nel 1975 l’edizione critica dei Quaderni del carcere, ma nessun intellettuale comunista italiano farà autocritica rispetto alla vulgata togliattiana che aveva guidato la composizione e la diffusione della prima versione a stampa dei Quaderni (1948-51), nessun intellettuale comunista italiano sentirà-comprenderà-capirà che Gramsci in gioventù era stato marxista, e comunista, e aveva fondato un partito comunista, certo, ma da grande, in carcere, pensando e scrivendo i Quaderni, era andato oltre il marxismo, oltre il comunismo, e addirittura oltre Marx.
Non hanno ascoltato Gramsci, figurarsi Pasolini – un poeta!
Domenica 21 agosto 2011
Mi trovo ad Acquasparta, un paesino umbro, per l’inaugurazione del Festival Federico Cesi. Viaggiando ho pensato alla passione pasoliniana per il decentramento. Di sera, al concerto, osservo giovani felici – le giovani donne organizzatrici, gli attenti ascoltatori. (“Questa nuova generazione di giovani, odiosa, nella massa, perché poi c’è un’infinità di eccezioni, ancora, abbastanza…”)
La notte, dopo il concerto, leggo Il Sole 24 Ore. In prima pagina una descrizione della XXVI Giornata Mondiale della Gioventù, presieduta da Benedetto XVI a Madrid: “Una folla gioiosa… Una stupenda tavolozza… Trasparenza, lealtà, limpidezza degli occhi dei giovani, del loro sguardo, del loro cuore… Alcuni media hanno dato evidenza a qualche chiassosa contestazione di ‘laicisti’ radicali… Questo hanno annunciato i giovani convenuti a Madrid: l’alternativa al vuoto di valori, all’assenza di senso, all’evasione egoistica e inconsistente, esiste, ed è l’impegno di amore al servizio del bene comune, sostenuto dalla fede…” Bruno Forte – Arcivescovo di Chieti-Vasto
Giovedì 25 agosto 2011
Leggere mi diverte sempre di più, mentre invecchio. E invecchio diventando sempre più leggero. Non per disperazione – come Pasolini, e nemmeno per speranza – come gli arcivescovi. Divento sempre più leggero perché con Pasolini so che “il mondo ha eterni, inesauribili, cambiamenti. Ogni qualche millennio, però, succede la fine del mondo.” (Paragrafo settimo del ‘trattatello pedagogico’ intitolato ‘Gennariello’, in Lettere luterane), ma questo per me non ha significato e non significa il crollo, come per Pasolini: “Il crollo del presente implica il crollo del passato. La vita è un mucchio di insignificanti e ironiche rovine.” (‘Abiura dalla Trilogia della vita’ – in Lettere luterane)
Da quegli anni, gli anni delle Lettere luterane, studiando i Quaderni di Gramsci, e sviluppandoli creativamente con Luis Razeto, ho compreso a fondo il carattere organico della crisi che stiamo vivendo, una vera e propria ‘crisi di civiltà’, che però non è ‘la fine del mondo’, in quanto è possibile, e dunque necessario, costruire una nuova e superiore civiltà, e questo intorno a noi si sta facendo, confusamente e contraddittoriamente certo, ma si sta facendo, per opera di alcuni tanti giovani felici e di alcuni tanti artisti e intellettuali, attraverso una produzione artistica e intellettuale creativa e autonoma e solidale -, produzione alla quale noi stiamo partecipando dalla metà degli anni Settanta con la costruzione di una nuova scienza, la scienza della storia e della politica: http://pasqualemisuraca.com/sito/index.php/scienza/50-la-traversata.html – http://pasqualemisuraca.com/sito/index.php/scienza/152-la-traversata.html
Pasolini ha visto e rappresentato il disfacimento della vecchia civiltà, non è stato capace di cogliere nella morte del vecchio la nascita del nuovo, in lui il morto afferrava il vivo (Marx), ma senza quella sua disperata descrizione non so quando avrei trovato il bandolo scientifico della matassa.
Ne rendo testimonianza.