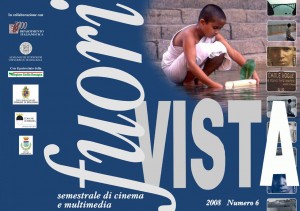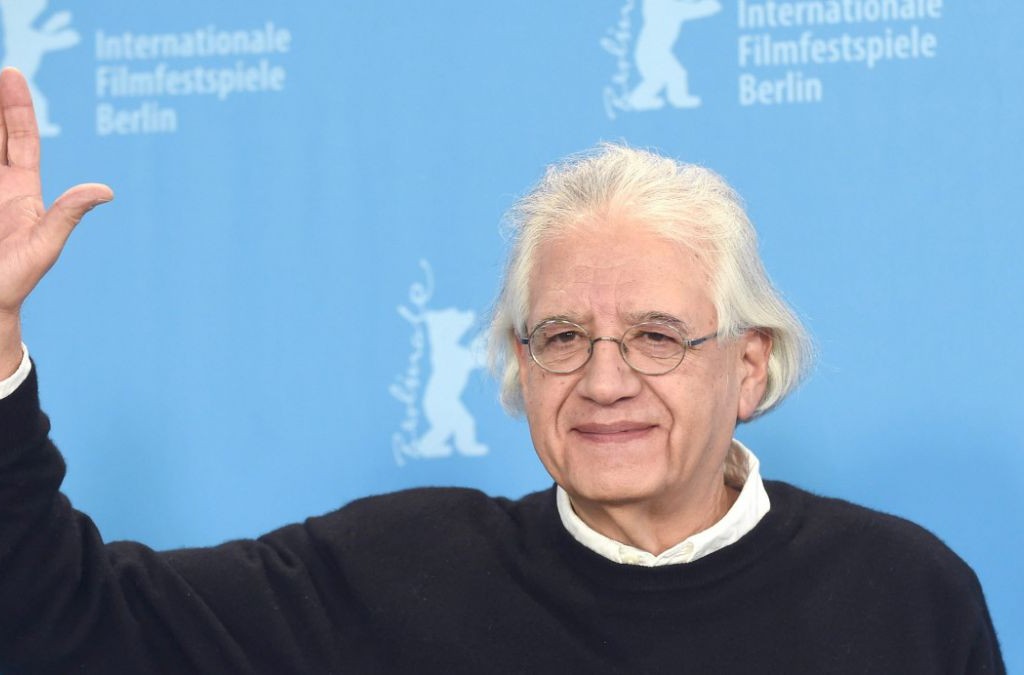L’INHUMAINE
di Fabio Matteuzzi
L’inhumaine, di Marcel L’Herbier, realizzato nel 1923 e proiettato per la prima volta nel 1924, festeggia quest’anno il secolo di vita.
Quando ci si avvicina a un film così distante da noi nel tempo dobbiamo fare uno sforzo per comprenderlo meglio. Uno dei modi migliori per farlo, oltre a lasciarsi invadere dalla visione del film, ponendosi quindi senza filtri di fronte al film, è di contestualizzarlo approfondendo il periodo storico e culturale in cui è stato pensato e realizzato. Percorso quest’ultimo ben diverso che ci obbliga ad andare oltre la visione, cercando quindi di documentarci meglio che possiamo, in particolare sul periodo e sulle modalità che hanno portato alla realizzazione del film.
“L’inhumaine era stato pensato come vetrina dell’arte modernista francese e anteprima dell’Esposizione delle Arti Decorative, che avrebbe avuto luogo nel 1925.”[1]
Per noi, la traduzione italiana del titolo (Futurismo – Un dramma passionale nell’anno millenovecentocinquanta) può essere fuorviante. Può farci credere che L’inhumaine sia un film futurista. In Italia, il futurismo esisteva già da oltre un decennio e si era sviluppato trovando terreno fertile in vari linguaggi artistici, dalla letteratura alle arti visive. Probabilmente, impregnato di modernismo, il film poteva prestarsi ad avere questo titolo, secondo la distribuzione italiana. L’inhumaine, realizzato in Francia, si situa senza dubbio in un periodo in cui è molto forte l’attività delle avanguardie storiche, dall’impressionismo al dadaismo, dal cubismo all’influenza dell’espressionismo tedesco. C’è in sostanza una compresenza sia nel film sia, evidentemente, nella consapevolezza dei realizzatori del film, certamente di Marcel L’Herbier ma anche dei collaboratori, di questo fermento che coinvolge varie forme artistiche, di reciproche influenze e di spirito di sperimentazione. Da questo punto di vista, L’inhumaine è il film chiave (come scrive Antonio Costa nel suo Il cinema e le arti visive[2]) per capire il rapporto tra il cinema e le avanguardie storiche. Lo stesso L’Herbier disse nella sua ultima intervista nel 1968 “volevamo che [L'inhumaine] fosse una sorta di riassunto provvisorio di tutto ciò che accadeva nelle arti visive francesi due anni prima della famosa mostra delle Arts Décoratifs.”
“Marcel L’Herbier, che considerava il cinema un’arte di sintesi, per questo suo progetto ottenne la collaborazione di alcuni dei più importanti artisti francesi degli anni Venti. L’architetto Robert Mallet-Stevens disegnò gli spogli e astratti esterni della villa di Claire e del laboratorio di Einar, Fernand Léger il laboratorio di ispirazione cubista, i cui ingranaggi rotanti, archi, cerchi e rettangoli avrebbero trovato un’eco nel suo contemporaneo Ballet mécanique. Alberto Cavalcanti disegnò il grande atrio in stile art déco della villa di Claire, dominato da una piattaforma a scacchi bianchi e neri che graficamente si accorda con le uniformi dei domestici. Claude Autant-Lara ideò lo stilizzato giardino d’inverno della villa e la camera funeraria, mentre lo stilista Paul Poiret creò per il personaggio di Claire i turbanti e gli scintillanti abiti a guaina ornati di pelliccia. René Lalique, Jean Puiforcat e Jean Luce realizzarono gli oggetti d’arredo, mentre Pierre Chareau disegnò i mobili e Raymond Templier i gioielli, Jean Dunand si occupò delle lacche e Joseph Casky delle sculture, Djo-Bourgois per i manifesti. Darius Milhaud compose l’accompagnamento musicale al film, oggi perduto. Jean Börlin e i Ballet Suédois appaiono sul palcoscenico del Teatro degli Champs-Élysées prima del concerto di Claire.”[3] In tutto questo, un ruolo importante lo ebbe Alberto Cavalcanti che coordinò questo gruppo di lavoro pur essendo alle sue prime esperienze cinematografiche.
Non dobbiamo peraltro dimenticare che il film è stato realizzato in Francia, ossia nel paese dove il cinematografo è nato, e dove si è sviluppata quella contrapposizione tra cinema legato alla realtà di quanto riprodotto sullo schermo (la cui radice possiamo rintracciarla nei fratelli Lumière) e la manipolazione del tempo e dello spazio, finanche dei corpi (la cui radice è invece legata ai film realizzati da Georges Méliès). Una distinzione che deve essere intesa più come suggestione perché non tiene conto, detta così, di tutte le sfumature che inevitabilmente esistono, basti pensare alla finzione già presente in alcuni film dei fratelli Lumière come L’arroseur arrosé.
Siamo nel 1924, il cinema esiste da poco meno di un trentennio. L’industria cinematografica ha già dato prova, in diversi paesi, di essere forte, e soprattutto di cercare sempre di più delle formalizzazioni che ancora non sono tali da sopprimere, come sarà di lì a poco, con l’avvento del sonoro, gli aspetti più originali e creativi, più artistici e meno commerciali che tutte le avanguardie, storiche e non, hanno nel loro imprinting. Siamo ancora, quindi, in un periodo in cui i cineasti hanno modo di sperimentare le possibilità del cinema, e come il cinema possa ancora, in parte essere inteso come qualcosa da scoprire ed esplorare.
L’inhumaine ha certamente degli elementi futuristi. Giovanni Lista, storico del futurismo ne cita in particolare un paio: il laboratorio dell’ingegner Norsen, interpretato nel film da Jacque Catelain, in cui troviamo le sculture animate di Fernand Lèger; il Jardin d’hiver della protagonista, la diva Claire Lescot interpretata da Georgette Leblanc, realizzato da Claude Autant-Lara.[4] Potremmo anche aggiungere la presenza, nelle prime sequenze del film, dell’automobile dell’ingegner Norsen e della esaltante velocità di questo nuovo mezzo, inteso non solo come uno strumento con cui muoversi fisicamente nello spazio, tra i luoghi, ma attraverso cui proiettarsi simbolicamente nel futuro.
Tuttavia, il film è tradizionalmente considerato all’interno dell’esperienza del cinema impressionista francese, che copre il periodo 1918-1929. Basti citare a questo proposito la Storia del cinema e dei film di Bordwell e Thompson.[5] L’inhumaine si colloca proprio al centro di questo periodo nei due anni, 1923 e 1924 che sono stati tra i più prolifici dell’impressionismo cinematografico francese (quindici in due anni). Tra l’altro sarà proprio con un altro film di L’Herbier (L’argent) che si chiuderà l’esperienza dell’impressionismo nel 1929, anno in cui venne realizzato anche Finis Terrae di Jean Epstein. Non è un caso, fu l’anno dell’introduzione del sonoro che segnò l’impossibilità di continuare a realizzare produzioni indipendenti.[6]
Il periodo fu importante non solo per la realizzazione di film che poi sono entrati nella storia del cinema, ma anche per una elaborazione teorica in grado di influenzare non solo i film ascrivibili all’impressionismo, che aderivano a questi dettami, ma anche del periodo successivo, in ambito teorico, critico ma anche realizzativo. In particolare, l’elaborazione teorica di un concetto di “fotogenia” che non si limitava al significato corrente del termine ma veniva articolato, come fece Louis Delluc come “qualità che distingueva l’immagine filmica dall’oggetto originale: trasformato in immagine, l’oggetto acquistava una nuova espressività, rivelandosi allo spettatore in una luce totalmente nuova.”[7] Ancora, Kirsanov affermava che “Ogni cosa esistente nel mondo vive un’altra esistenza sullo schermo.”[8] Questo concetto si collegava quasi fatalmente all’idea che fosse la macchina da presa stessa ad avere questo potere, strappando l’oggetto dal suo contesto per trasformarlo, complice l’impatto del bianco e nero e dei fenomeni ottici che le lenti erano in grado di provocare. Quindi, per i teorici impressionisti, lo spettatore cinematografico poteva essere condotto a provare un’esperienza nuova che solo il cinema poteva offrire. Attraverso la macchina da presa e questo concetto di fotogenia lo spettatore poteva sperimentare “l’anima delle cose e l’essenza degli oggetti.”[9]
Ci si allontanava in tal modo da modalità rappresentative precedenti, soprattutto teatrali e letterarie. Si avviava anche una discussione sulla fotogenia che avrebbe attraversato la storia del cinema, in cui l’interpretazione teorica impressionista avrebbe lasciato un segno profondo. Citiamo ancora uno dei maggiori esponenti dell’impressionismo, Jean Epstein: “Che cos’è la fotogenia? Chiamerò fotogenico ogni aspetto delle cose, degli esseri e delle coscienze che accresca la sua qualità morale attraverso la riproduzione cinematografica.”[10]
Nel 1922 era stato realizzato un film che avrebbe cambiato il cinema francese e che dimostrava tutto questo: La roue di Abel Gance. In merito a questo Germaine Dulac disse: “Si può commuovere senza personaggi, dunque senza artifici teatrali: guardate la canzone della rotaia e delle ruote. Un tema, non un dramma. […] La rotaia, una strada di acciaio rigido, inchiodata, la rotaia, quanto di più lontano dalla vita, una poesia le cui rime sono le linee mobili e semplici, che poi si moltiplicano. Mai il cinema è stato, a mio parere, più all’altezza di sé stesso che in questo breve poema dovuto al nostro maestro Abel Gance. Giochi di luci, giochi di forme, giochi di prospettive. Un’emozione intensa dovuta alla visione di una cosa sensibilmente percepita. Poi le ruote, un ritmo, una velocità… Una biella il cui movimento meccanico segue il ritmo di un cuore.”[11]
A monte di tutto questo c’era la convinzione degli autori del cinema impressionista che il cinema fosse una forma d’arte anche se ancora non sufficientemente riconosciuta. Quindi si ponevano come artisti, nei confronti dell’opera e nei confronti degli spettatori mirando a evocare non ad affermare, e a fare provare sensazioni ed emozioni allo spettatore. Attraverso il lavoro dell’arte si doveva arrivare allo spettatore facendogli provare sensazioni ed emozioni, riprendendo in tal modo, in maniera aggiornata, elementi dell’estetica romantica e simbolista, propria della fine del secolo precedente.
Altro aspetto importante dal punto di vista teorico era la considerazione che il cinema fosse la forma d’arte ideale in quanto sintesi di tutte le altre arti. Tutte venivano combinate all’interno del cinema. Questo portò alla considerazione di un cinema non legato alla narrazione, un cinema puro (cinéma pur) basato sull’astrazione dove primeggiavano relazioni visive, grafiche e temporali. Ciononostante, non tutti aderivano a questa idea radicale.
Per quanto riguarda L’inhumaine vale la pena notare come il film presenti aspetti innovativi dal punto di vista visivo ma tradizionali per quanto riguarda la linea narrativa. Il titolo originale del soggetto scritto da L’Herbier su sollecitazione di Georgette Leblanc, che sarebbe stata la protagonista, era La Femme de glace. Donna di ghiaccio, la cui insensibilità viene sintetizzata nel titolo definitivo L’inhumaine, “colei che non corrisponde all’amore di qualcuno.”[12] Georgette Leblanc era stata una cantante, un soprano, molto apprezzata di cui si ricorda soprattutto l’interpretazione della Carmen di Bizet. Sposò il poeta Maurice Maeterlinck. Visse anche negli Stati Uniti e fu proprio al suo ritorno in Francia dagli Stati Uniti che propose a L’Herbier “la produzione di un film capace di attestare le tendenze ‘moderne’ dell’arte francese e dove lei stessa doveva figurare come protagonista”.[13] Dietro questa proposta ci sarebbe stato anche l’interesse di Otto Kahn e di finanziatori americani.
La storia, di per sé è molto semplice e lineare e contrasta con il modernismo degli aspetti visivi e spazio-temporali. Si può dire quindi che proprio partendo da questi aspetti narrativi venivano esplorate le possibilità espressive del cinema dal punto di vista soprattutto figurativo. Siamo quindi davanti a un elemento importante: la storia, la narrazione è solo relativamente importante, in realtà è solo un mezzo attraverso cui l’elaborazione artistica visiva (e anche sonora) assume il dominio.
Molto sinteticamente: la protagonista del film, L’inhumaine è Claire Lescot una famosa cantante circondata da uno stuolo di ammiratori, come ogni diva che si rispetti. Tra questi l’inventore Einar Norsen (interpretato da Jacque Catelain) e il geloso maharaja indiano Djorah de Mopur (interpretato da Philippe Hériat). Tutti gli uomini che gravitano attorno al “salotto” della cantante e che sono presenti alla festa che si svolge nella sua villa sono ossessionati da lei. Per la forte gelosia il maharaja uccide la cantante e Norsen, infine, la fa tornare in vita con uno strumento di sua invenzione.
L’aspetto determinante de L’inhumaine – come già evidenziato – è quindi costituito dall’architettura e dalla scenografia, dalla presentazione degli ambienti, interni ed esterni, dall’utilizzo di tecniche cinematografiche come sovrimpressioni, sfocature, sfruttando tutto ciò che le pratiche di montaggio potevano offrire.
Fondamentale fu appunto la collaborazione di più persone che andarono a costituire un gruppo di lavoro di alto rilievo coordinato da Alberto Cavalcanti.
[2] Costa Antonio, Il cinema e le arti visive, Torino, Einaudi, 2002, p. 198.
[4] Lista Giovanni, “La componente futurista ne L’inhumaine” in Canosa M. (a cura di) Marcel L’Herbier, Pratiche, Parma, 1985, pp. 148-55. Cfr. Costa, op.cit., p. 200.
[5] Bordwell David, Thompson Kristin, Storia del cinema e dei film, Milano, Il Castoro, 1998, vol. 1, p. 139-143.
[6] A questo proposito, in un’intervista del 1968, L’Herbier disse:
“Quando fu introdotto il sonoro, le condizioni lavorative divennero molto difficili per un regista come me. Per ragioni economiche, era impensabile poter realizzare film come quelli che avevamo fatto nel periodo muto, neanche a spese dell’autore. Bisognava limitarsi notevolmente e adottare forme cinematografiche che, almeno per quello che mi riguarda, avevo sempre disprezzato. Di colpo, grazie al parlato, eravamo costretti a mettere in scena stantii brani di teatro, puri e semplici.” In Fieschi Jean-André, “Autour du cinématographe. Entretien avec Marcel L’Herbier” Cahiers du Cinéma, n. 202, giugno-luglio 1968. Cfr. Bordwell, Thompson, op cit. p. 153.
[7] Ibid., p. 143.
[8] Ibid. cfr. Kirsanov Dmitri, “Problème de la photogénie”, Ciné-Ciné pour tous, n. 62, 1 giugno 1926. Curioso: mentre veniva pubblicato questo articolo sulla fotogenia nasceva, a Los Angeles, Marilyn Monroe.
[9] Ibid.
[10] Epstein Jean, “Alcune considerazioni della fotogenia” (1923), in Cinema & Cinema, nuova serie, anno 19, maggio/agosto 1992, n. 64.
[11] In Cinémagazine, 19 dicembre 1924 cfr. Mitry Jean, Storia del cinema sperimentale, Milano, Mazzotta, 1977, p.79.
[12] Canosa Michele (a cura di), Marcel L’Herbier, Parma, Pratiche, 1985, p. 35.
[13] Id. p. 69.