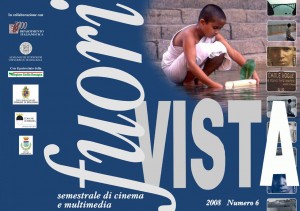di Fabio Matteuzzi
A quanto mi risulta, per molto tempo in nessuna filmografia di Ingmar Bergman è stato citato il cortometraggio Il ballo delle ingrate (De fördömda kvinnornas dans), girato in bianco e nero nel 1976, neppure nelle più accurate, come ad esempio quella, pur ricca, contenuta nell’autobiografia dello stesso Bergman, Immagini.(1)
Il ballo delle ingrate presenta interessanti peculiarità. Tra queste una è particolarmente evidente e guida le motivazioni registiche e coreografiche del film.
Il ballo delle ingrate dura complessivamente 24 minuti. Nell’arco di tale durata il nucleo portante del film (le sequenze in bianco e nero, contrapposte alla presentazione e all’intermezzo, girati a colori) è proposto due volte alla visione dello spettatore. Non si tratta, tuttavia, di una mera ripetizione. Non può esserlo per almeno due motivi. Uno congenito, per così dire, l’altro dovuto a una serie di contestualizzazioni fornite solo prima della seconda proiezione.
È noto che qualsiasi seconda visione contribuisce ad arricchire lo spettatore di una maggiore conoscenza dell’opera. Tuttavia non intendo qui disquisire su un principio ormai largamente accettato.(2) Intendo piuttosto richiamare l’attenzione ai diversi presupposti che ci vengono dati, all’interno stesso de Il ballo delle ingrate, prima della proiezione dei due pezzi “uguali”, stabilendone quindi criteri per la comprensione, una nuova posizione dello spettatore, meno passiva di fronte alle immagini che si susseguono sullo schermo. Ammesso che non sia sufficiente, di per sé, la proiezione a dar vita al materiale filmico, il cui grado di amorfismo è forse solo apparentemente (grazie al movimento) minore a quello di un dipinto o di un testo scritto che debbono essere vivificati dall’interpretazione/partecipazione, quindi di un uso, tuttavia l’operazione compiuta da Bergman amplia quello spazio in cui la consapevolezza di chi fa e quella di chi partecipa come spettatore, si incontrano.
Il film inizia con una presentazione, a colori, che ci informa che ciò che stiamo per vedere è una composizione coreografica, ma non un balletto. Fatto che comprenderemo meglio durante la visione del film, composto quasi esclusivamente da primissimi piani, primi piani e dettagli. A questo fa seguito quello scarto (preannunciato) contrassegnato visivamente dal passaggio al bianco e nero, che, dal punto di vista dello statuto fotografico del film appartiene al cortometraggio vero e proprio. Una volta conclusosi, Bergman inserisce un intermezzo, anch’esso a colori, in cui vengono illustrati alcuni presupposti serviti come fondamento per l’elaborazione de Il ballo delle ingrate, grazie a cui è possibile vedere sotto nuova luce il film, che viene appunto ripetuto.(2)
Come già accennato, abbiamo dunque una doppia visione dello stesso filmato. La prima nell’ignoranza delle intenzioni interpretative(3) ed espressive di Bergman e di Donya Feuer, che ha curato la coreografia. La seconda resa particolarmente fertile in seguito all’esposizione delle motivazioni interpretative perseguite dagli autori.
In tal modo, prima viene dato spazio alla elaborazione emotiva e percettiva dello spettatore, poi lo si informa sui motivi che hanno guidato la realizzazione di ciò che ha visto e gli si permette un nuovo confronto, che, a questo punto, non riguarda solo il film, ma il rapporto con ciò che ne ha informato l’impostazione registica.
Tutto ciò non ha nulla di banalmente didattico. Bergman sa evitare il didascalico. D’altra parte non si riserva il diritto all’ultima parola. Dopo che le intenzioni degli autori sono state illustrate, il film viene ripetuto proprio per permettere una nuova visione e una nuova rielaborazione, autonoma e guidata a un tempo, da parte dello spettatore.
Lo spettatore è messo nella condizione di provare l’esperienza di un mutamento del proprio rapporto con un medesimo brano filmato. Al di là dell’opportunità di essere messo al corrente delle principali intenzioni degli autori, ciò che più importa è la possibilità di verificare immediatamente queste chiavi di lettura, ufficialmente ammesse, attraverso la propria attenzione e conoscenza. In una parola: si tratta di compiere un atto critico. Non di accettare come esauriente la spiegazione data a voce nell’intermezzo tra la prima e la seconda visione,(4) ma di farla propria, di valutare gli intenti e l’elaborazione registica sulla base di una riflessione che metta in relazione gli assunti interpretativi degli autori e ciò che risulta dal rapporto interno tra le due visioni del film da parte dello spettatore. Se Il ballo delle ingrate ha valore sperimentale, è in questo aspetto che può rivelarlo. Nello stabilire percorsi di lettura validi come basi per una valutazione critica (e non) non legata meramente al gusto di chi guarda, non dipendente dall’adesione o meno allo stile di un regista, ma capace di mettere in gioco sia lo spettatore sia gli autori stessi. Fornendo basi per una verifica dei risultati degli intenti e dell’interpretazione filmica proposta, fermo restando che forse, il risultato più evidente è lo sconcerto, da parte dello spettatore, nel percepire perfettamente la diversità della propria esperienza di fronte alla visione ripetuta di un medesimo film.
Il film è sempre lo stesso, ma ora egli possiede alcune indicazioni, alcuni piccoli strumenti che gli consentono di muoversi con meno approssimazione all’interno dello stesso. Ciò che sa non è tutto ciò che si può sapere su Il ballo delle ingrate, è solo una parte delle cose che hanno guidato il lavoro di Ingmar Bergman e Donya Feuer, le meno complesse, le più superficiali,(5) e tuttavia ciò è già così tanto, che gli consente di non aggrapparsi al salvagente delle sensazioni o alle sollecitazioni del gusto, provando, invece, il gusto di una pur piccola conoscenza dell’opera, che è ben raro riuscire a cogliere nel tempo in cui viviamo, immersi in una società e nelle estetiche “moderne”, di fronte a qualsivoglia manifestazione artistica. E ciò implica una più sentita e diretta partecipazione all’opera, invece di una indecifrabile affinità o avversione all’autore. È evidente allora come basti poco per rompere le barriere della mera visione cinematografica.
In seguito alla prima visione del film ci viene detto che esso venne realizzato successivamente a Il flauto magico (1974),(6) che ne influenzò la realizzazione, soprattutto per le scene in cui anime di dannati espiano le proprie colpe. Ciononostante, limiterei la suggestione che può offrire questa affermazione. L’idea originaria può senz’altro essere nata, in Bergman (perché metterlo in dubbio?) durante la lavorazione de Il flauto magico, ma è difficile vedervi, sostanzialmente, nulla più che un valore di stimolo, fonte che ha permesso l’intuizione di un tema da sviluppare, distaccandosi tuttavia, anche molto, da qualsiasi elemento che permetta un’associazione critica o stilistica alla trattazione dell’opera mozartiana.
Di fatto, se lo spunto è stato offerto a Bergman da alcune scene dell’opera di Mozart, il cortometraggio, così come è stato realizzato, ha, senza dubbio, un punto di riferimento ben più diretto.
Anche in questo caso si tratta di un referente musicale, che porta il nome del titolo del film. Si tratta de Il ballo delle ingrate (1608) di Claudio Monteverdi, musicato su testo di Ottavio Rinuccini, utilizzato come colonna sonora del cortometraggio.
Tra l’influenza (dichiarata) che l’allestimento cinematografico mozartiano ha permesso e quella geneticamente dovuta all’opera omonima, Bergman adatta una situazione drammatica in cui appaiono figure di “dannati”. Nel film, tuttavia, l’interpretazione attualizza la “dannazione”.
Nell’opera di Monteverdi, le quattro donne sono, in realtà, quattro anime dannate (7) che vengono richiamate dagli inferi per mostrare ciò che accade a coloro che rifiutano in vita le dolcezze dell’amore. Ed è solo all’ultima parte dell’opera, in cui ha luogo questa evocazione, che Bergman e la Feuer si rifanno, condensando tutta l’azione nel passaggio più cruciale, quello dell’apparizione delle anime ingrate e il loro tornare a scomparire dietro «le tenebrose porte.»
Scompare ogni intento allegorico per aprire la strada alla rappresentazione di una condizione psicologica. In questo senso, senz’altro la versione e i presupposti interpretativi di Bergman e della Feuer possono dirsi a pieno titolo contemporanei.
Nel film, le quattro donne (due giovani sorelle, una donna un po’ più anziana e una bambina) sono chiuse in una stanza. Nessuno evoca la loro presenza. Esse si muovono all’interno di un luogo, fisico e psicologico, chiuso. La loro condizione di donne è espressa da questa chiusura di cui è la donna più anziana a farsi garante e a proibire istinti ribelli da parte di una delle due sorelle, le quali finiscono per adeguarsi, contribuendo loro stesse ad attirare anche la bambina, l’unica che senta ancora la propria appartenenza ad un mondo differente da quello costrittivo che è già pronto anche per lei, un mondo in cui il desiderio può ancora essere vissuto. La dannazione, in sostanza, non è il rischio di un’al di là, ma è già vissuto in questo mondo.
Secondo le intenzioni di Bergman e della Feuer «La stanza chiusa entro la quale le donne si muovono, simboleggia il mondo ristretto nel quale sono costrette a vivere. Il loro stato di recluse le spinge fatalmente a opprimersi le une con le altre».
In questo ambiente chiuso, la macchina da presa segue i movimenti delle protagoniste, per molto tempo lenti, poi improvvisamente rabbiosi e immediatamente soffocati. Il movimento dell’una inizia, spesso, dove finisce quello dell’altra, lo prosegue e lo varia. La mano aperta (di cui ci viene mostrato solo il dorso) della donna più anziana, che dà il via e il tono a tutti i movimenti seguenti, prolifica e irrobustisce, di passaggio in passaggio, fino al finale in cui le mani aperte delle tre donne chiudono la bocca, gli occhi e le orecchie della bambina.
Si ritrova la costante ricerca stilistica bergmaniana concentrata sui volti e sulla grande capacità che possono avere i primi piani se li si sfrutta perseguendo un dinamismo che fa sì che i volti dei personaggi, anche quando esprimono un’attesa, non esprimono una staticità, ma sono invece fonti di inesauribile comunicazione. Se si vuole Il ballo delle ingrate può essere considerato come uno studio sull’espressività dei volti e dei corpi, attraverso cui si manifesta solitudine e soffocamento.
Un film di primissimi piani e dettagli, di volti e di mani che sorgono dal buio quasi in apparente discontinuità dal resto del corpo, in cui al gesto è demandata, più che una cosiddetta resa espressiva, il senso del compiersi di un atto, in un prolungamento o in un rifiuto che lo rapporti e lo accomuni agli altri personaggi. Un film di riprese rigorosamente frontali e di profili, che segnano linee perfette. La creazione di un rapporto tra più volti, esclusivamente attraverso immagini che drammatizzano visivamente la cadenza musicale, invenzioni di movimenti tra luce e oscurità. La gestualità, del resto, segue due percorsi che si contrappongono. I gesti di avvicinamento, di attrazione e quello di ripulsa, di fuga.
Meno chiara è invece l’espressività del volto, più oscillante, quando si tratta di trasmettere stati non estremi, quali la dolcezza, o la disperazione). Allora è proprio quando le mani si toccano, scivolando incerte lungo un muro, o quando i volti, su piani di ripresa differenti, si sovrappongono, che si riconduce visivamente a un destino comune l’individualità di più personaggi.
Tutto ciò è un marchio stilistico inconfondibile in questo quartetto di donne che compone nel finale, in una forzata pacificazione, anzi, in una vera e propria repressione, tutte le variazioni precedenti su cui si erano alternati duetti, trii e assoli.
Il quartetto è una delle forme musicali più ardue. Pretende attenzione e conoscenza anche da parte dell’ascoltatore. Cede poco al fascino delle emozioni. In ambito cinematografico l’idea di questa forma ha qualche costante, che anche altri hanno rilevato,(8) ed è tuttavia tutta da scoprire e da verificare. Aggiungerei che più che una costante relativa ad alcuni autori, riguarda necessariamente un’idea di forma cinematografica. D’altra parte, abbinare la forma “quartetto” alla presenza di quattro personaggi, per quanto possa sembrare banale, è un passo selettivo irrinunciabile. Questa forma rigorosa non è nuova in Bergman. In particolare si può citare un breve accenno tratto dalla monografia di Tino Ranieri dedicata a Bergman e pubblicata da La Nuova Italia,(9) dove viene detto: «Modellato su un quartetto d’archi (la fuga n. 2 in fa minore per violoncello di Bach) Come in uno specchio è anche un quartetto di figure.»(10)
Il quartetto cinematografico presenta delle caratteristiche formali grazie a cui i rapporti tra i personaggi, e tra i personaggi e il mondo in cui sono stati gettati, si concentrano, si condensano, fino a esplodere (secondo un termine usato proprio da Ranieri a proposito di Come in uno specchio).
Come abbiamo detto, la forma del quartetto non è una novità per Bergman (il brano di Ranieri è lì a dimostrarlo), che la utilizza consapevole delle possibilità che un tale schema rigoroso permette rispetto alla presenza e all’intrecciarsi dei personaggi, al loro continuo apparire e scomparire, al cedere l’un l’altro gli spazi, o a predominare con scarti repentini l’uno sull’altro.
La macchina da presa segue costantemente il gesto, il movimento del corpo, e la coreografia consente movimenti plastici che una più consueta presenza attoriale non saprebbe dare. In questa operazione riesce a soffermarsi quel tanto che basta per cogliere una trasformazione su un volto (dal sorriso a una cupezza e insensibilità quasi catatonica, per esempio, sul volto della bambina ogni volta che la si distolga dalla sua bambola) che riempie di senso una particolare scena.
Si può dire, così, che Bergman ritrova ne Il ballo delle ingrate la possibilità espressiva di un’idea, di una forma a cui era autonomamente pervenuto già diversi anni prima,(11) e che questa forma “impura” si propone come qualcosa che va al di là della riduzione alle caratteristiche stilistiche di un autore, ma è piuttosto una forma a cui più di un autore ha saputo dar vita, e solitamente con risultati eccellenti, o interessanti.(12) È dunque un altro aspetto che questo piccolo cortometraggio possiede. E sono soprattutto questi aspetti, l’intenzione che soggiace alla ripetizione di un brano filmato e quello, formale, del “quartetto cinematografico”, piuttosto che l’adesione a un tema e l’interpretazione che ne è data, a dare maggiore valore a Il ballo delle ingrate. Valore che non è quello di una originalità, di una presunta invenzione, ma di una profondità, di chiamare lo spettatore a conoscere meglio i presupposti di un’opera per arrivare a comprendere l’opera, e di metterlo a confronto con uno schema semplice, in un certo senso canonico, in cui i personaggi giocano un ruolo insostituibile che tuttavia non è né principale né secondario rispetto a quello degli altri.
13) Vorrei citare solo alcuni film che potrebbero rientrare in uno studio apposito: Muriel e L’amour a mort