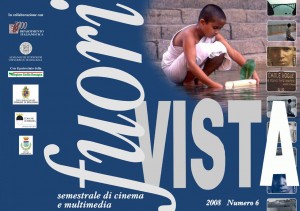di Fabio Matteuzzi
“Negli ultimi anni della prolifica vita di scrittore di Georges Simenon, quando aveva già pubblicato quasi 400 romanzi, Alfred Hitchcock raccontò di avergli telefonato, solo per essere informato dal segretario di Simenon che non poteva essere disturbato perché aveva appena iniziato una nuovo romanzo, Hitchcock, sapendo che Simenon era capace di scrivere un romanzo – o due o tre – ogni mese, rispose: ‘va bene, aspetterò′ “.
(Estratto dalla recensione di Deirdre Bair “Simenon, una biografia” di Pierre Assouline, The New York Times)
Georges Simenon scrisse, all’inizio degli anni Quaranta La finestra dei Rouet, pubblicato solo nel 1945, a guerra terminata. Recentemente, l’editore Adelphi, proseguendo nel progetto editoriale di pubblicazione dell’opera omnia di Simenon, ha pubblicato l’edizione italiana con la traduzione di Federica Di Lella e Maria Laura Vanorio.
Troviamo, come sempre in Simenon, una forte caratterizzazione di tutti i personaggi; anche quelli di sfondo sono precisamente delineati, quasi scolpiti in una vicenda in cui il tempo sembra scorrere lentamente e i luoghi delineati molto chiaramente, al punto che ci troviamo in spazi limitati e ristretti e non è più possibile parlare di orizzonte. Le coordinate spazio-temporali, e infine narrative sono quelle che la protagonista, Dominique, costruisce e subisce. Il mondo di Dominique è totalmente interiore. Dal suo appartamento, reso ancora più piccolo dal fatto che ha ceduto una camera in affitto a una giovane coppia, osserva il mondo esterno. Ma il suo non è un semplice osservare, una semplice visione, è una vera com-partecipazione, l’anticipazione delle cose che stanno succedendo. E’ talmente presa dalle cose che vivono intorno a lei che è la sua stessa vita a trarre linfa dalla vita altrui. In particolare Antoinette, sposa del figlio dei signori Rouet, così diversa da lei, così esuberante. Tuttavia solo essa conosce - sembra conoscere – così a fondo i segreti che turbano Antoinette. Antoinette che non fa nulla per salvare il marito quando questi, nella stanza accanto ha una crisi cardiaca. Antoinette tiene in mano il bicchiere con la medicina che potrebbe salvarlo, fino a quando il parossismo della crisi lo uccide. Solo allora lei prova imbarazzo, poi fa sparire la medicina versandola in un vaso. Dominique vede tutto, ha sempre visto tutto, ormai è esperta nel carpire non solo le parole, ma i pensieri di chi le vive di fronte, sconosciuti senza segreti. Dalla sua postazione poteva vedere attraverso una finestra Antoinette con il bicchiere in mano, attraverso l’altra il marito che stava avendo la crisi fatale.
Nella penombra della sua stanza, della sua vita, Dominique riesce a fantasticare, a sentirsi vivere, solo quando osserva il suo corpo riflesso nello specchio, incorniciato nel contorno dello specchio, come incorniciate sono le altre vite, oltre le rispettive finestre, al di là delle porte, visibili attraverso la sagoma del buco della serratura. Le visioni rubate ai vicini la turbano, ma di fronte allo specchio, mentre tocca il proprio corpo nella penombra, il turbamento si unisce a una sorta di conforto. In quei momenti sospesi, quando il proprio corpo le appare riflesso dallo specchio, contenuto nello specchio, quasi si stupisce di avere un corpo tutto suo, tale da poterlo sentire, accarezzandolo e stringendolo con le mani, accorgendosi come, nonostante abbia già quarant’anni, sia ancora fresco e vivo, come se non fosse mai cambiata, come fosse ancora giovane. Anche il suo corpo desidera, ma il desiderio viene, come sempre represso. Scruta il suo corpo come una qualsiasi delle persone che vivono fuori, in quel mondo che lei riesce ad abbracciare con lo sguardo e con un proprio acuto sentire. Tutti i sensi sono allora vigili, per cogliere qualsiasi cosa possa fornire un ulteriore tassello di quel mosaico di cui lei, sempre di più, non può fare a meno.
I confini del mondo di Dominique sono quelli dei suoi pensieri, della propria casa, e di ciò che può vedere dalla finestra. Sola, senza famiglia, senza i genitori, morti da tempo, ma di cui continua ad aleggiare la presenza, soprattutto quella dell’autoritario padre generale che continua a osservarla dal dipinto appeso alla parete, senza amicizie e senza lavoro, Dominique affitta la stanza a una giovane coppia. Ne assorbe la vita, così come fa con tutti i vicini di casa su cui posa lo sguardo con intensità, per abitudine, per necessità, intuendone in anticipo i gesti, le parole, le intenzioni. E’ attenta alle voci, alle risa, ai bisbiglii, all’intonazione della voce, ne interpreta le intenzioni, ma al centro c’è lei stessa, sensibile a qualsiasi lieve intonazione possa farle percepire una riferimento a lei stessa, fino a percepire i sorrisi: “Sorridevano al pensiero della loro padrona di casa spogliata. Perché? Con che diritto sorridevano? Cosa sapevano di lei?” (p. 145)
Per Dominique sentire la vita accanto, non dentro di sé, non è cosa nuova, ma esperienza che le è sempre appartenuta. Così quando ricorda – durante il corteo funebre di Hubert Rouet – eventi ormai lontani nel tempo, Simenon, improvvisamente tornando al presente, la inchioda a una chiosa che non ammette discussioni: “La colpiva tutto ciò che significava vita, anche Lina, la sua affittuaria, e spesso passava ore a lottare con se stessa, attratta da quella porta che le separava, da quella serratura attraverso cui potere guardare.” (p. 43)
Da un lato, va subito anticipato, la lettura del romanzo di Simenon, conduce, chi l’ha visto e apprezzato,in maniera inevitabile, all’ambientazione de La finestra sul cortile, il film realizzato da Alfred Hitchcock nel 1954, tratto a sua volta da un racconto di Cornell Woolrich. I legami tra le due opere sono forti all’apparenza, in realtà si fermano alla definizione di un mondo chiuso e all’oscillazione tra realtà e fantasia di cui entrambi si nutrono, tuttavia, come vedremo, in forme affatto diverse.
L’osservazione da lontano dei dirimpettai – da parte di Dominique – ma anche delle persone che abitano la sua stessa casa, di ciò che la circonda, pur presentandosi sotto il senso della visione, comporta in realtà una profonda attenzione e partecipazione di tutti i sensi: udito, tatto, odorato e, sì, anche gusto. Simenon, peraltro, è scrittore sempre attento anche a questi aspetti, che ritroviamo riccamente seminati nei suoi libri. Ciò che colpisce i sensi libera quel rapporto tra presente e passato in cui la memoria torna e quasi soggioga il presente. Un profumo fa riemergere un vissuto antico che ora sovrasta e cancella, sia pure per brevi istanti il presente lasciandola tramortita e inadeguata all’attimo che sta vivendo. Dominique non solo è conoscitrice di profumi riconoscibili, ma anche di quelli non descrivibili, che sono per lei precisi ed evocatori, da avere quasi una valenza “semantica”. Così lei, fin da bambina conosceva “l’odore delle strade all’alba”. Così il funerale di Hubert Rouet prosegue tra ricordi improvvisi, balzi di attenzione, segnati da elementi che vanno a turbare e dirigere i sensi in un altro tempo e luogo, facendosi invadere da ricordi e da un presente distorto: “Inconsciamente, Dominique si abbandonava con una sorta di voluttà al suono dell’organo, al profumo dell’incenso che le ricordava l’infanzia e le messe mattutine della sua fase mistica.” (id.) (..) “Subito dopo qualcosa la colpì, per un attimo si chiese cosa fosse, annusò l’aria e riconobbe, misto all’odore greve dell’incenso, il profumo delicato che Antoinette Rouet lasciava dietro di sé.” (p. 45)
Siamo a un funerale dove l’attenzione è distratta. E’ uno dei rari momenti in cui Dominique si trova all’aperto. Non è il suo mondo, lo si capisce. E’ talmente vicina alle persone e alle cose che non riesce a vederle davvero, o meglio non riesce a vederle oggettivamente, né attraverso quella distanza che la rende onnisciente come quando osserva il mondo dalla finestra o dal buco della serratura. Questo aspetto confuso tornerà, drammaticamente, in una sorta di preludio alla fine del romanzo, quando Dominique sarà abbordata per strada, da uno sconosciuto. Sono gli altri sensi, in questo caso in particolare l’odorato, che la guidano, o meglio la isolano tra la folla, offrendole fantasie in cui, suo malgrado, si abbandona, per quanto lontane e spiacevoli possano essere. Infatti è solo una volta tornata a casa che “Aprendo la finestra, Dominique accolse con sollievo lo spettacolo offerto dalle stanze di fronte..” (p. 45) E’ tornata a casa. E’ di nuovo a suo agio: nell’ambiente che conosce; qui può tenere a distanza il mondo, qui può vedere senza che gli altri la vedano. Gli altri non sanno neppure della sua esistenza. Frapporre una finestra, una particolare forma di barriera, mettere in cornice la vita degli altri e assorbirla. In altri termini, forse un po’ brutali, è solo quando Dominique torna a vedere – a fare prevalere il senso della vista sugli altri – che prova paura. E’ con la vista che riesce a tenere a distanza e ad avere le cose sotto controllo.
Ogni tanto, anche Dominique deve uscire. Non lo fa per scelta, non perché le piace, per un desiderio, per la leggerezza di una passeggiata, bensì per ubbidire a qualcosa dentro di sé che la spinge a farlo. Fuori si trova a disagio. E’ inquieta. Spesso anche quando esce non sa slegarsi dal senso della vista, non sa fare a meno della dittatura di un desiderio a cui la vista presta i suoi mezzi. A volte lo fa per seguire Antoinette, di cui scopre una relazione con un uomo, cosa che sapeva già, o che intuiva, oppure per seguire il signor Rouet, le sue inattese scappatelle all’insaputa della moglie. Un pezzo del mondo che osserva dalla finestra se ne va per la città e lei lo segue, per paura di perderlo, per sapere ancora di più sulla vita di chi ormai fa parte della propria, ne ha sostituito la parte più aperta all’esterno, la parte che può fare a meno del suo sguardo. Senza di loro è perduta. Senza di loro è preda degli altri sensi, che non sa governare, che implicano una maggiore vicinanza agli oggetti, alle persone, immergendola in un mondo che non sa vivere, perché non è mai stato il suo, nessun mondo, al di là della sua casa. A dire la verità fa anche un viaggio lungo, per partecipare a un altro funerale, questa volta di una zia. I parenti riuniti per l’occasione sono ormai estranei, alcuni fatica a riconoscerli mentre lei non sembra cambiata. “Nique non è cambiata! Nique non è cambiata! Glielo ripetono come se fosse l’unica della famiglia ad avere sempre avuto la stessa età, quarant’anni, come se fosse sempre stata una zitella.” (p. 139)
In esterno il mondo non è più ordinato e conosciuto, ma confuso, impossibile da contenere con lo sguardo: “Le macchine e gli autobus, le luci e la folla, una specie di fiumana da attraversare, da sfiorare, l’angolo di una strada da svoltare di volata e, passata una salumeria, una soglia da varcare, una targa di marmo nero con una scritta storta, un corridoio stretto che odorava di liscivia.” (p. 148) Tutti dettagli che non si risolvono in una immagine compiuta, frammenti inutili di un mondo che Dominique si trova ad affrontare senza conoscerlo, senza strumenti per controllarlo.
E’ solo verso la fine del romanzo, quando il suo personaggio è stato minuziosamente costruito che Simenon si permette di affermare: “Così, anche quella mattina, Dominique viveva per metà nella realtà presente e per metà di immagini di altri tempi.” (p. 163)
Ma quello è un giorno particolare, il giorno in cui tutto, inaspettatamente, per Dominique finirà. Quella che appare una scelta di Dominique, quella di uscire di casa, frettolosamente, per cercare Antoinette, per le strade della città in realtà risponde a una differente urgenza. Non c’è scelta, perché non c’è riflessione. La mattina Dominique si impegna nelle faccende domestiche, e già presagisce con timore cosa la attenderà quando avrà concluso i lavori casalinghi. Alle tre di pomeriggio ha già terminato tutto e diventa preda di quella che possiamo senza troppo indugio definire “accidia”, ma c’è, inspiegabilmente rapido, improvviso, il rifiuto di questo sentimento. Qualcosa si impossessa di lei, la spinge fuori per il mondo. Sembra essere preda di una forza a cui non sa opporre resistenza e che la farà perdere. Dominique teme questo momento. Lo ha già provato. E’ verso le tre del pomeriggio che tutto questo diventa insostenibile
“Alle tre aveva finito di dare la cera ai mobili.
Sapeva già che cosa stava per succedere, almeno quello che sarebbe successo nell’immediato.
Quando non avrebbe avuto più niente da fare, quando con un gesto rituale avrebbe posato sul tavolo la cesta delle calze, quando la luce avrebbe incominciato a farsi livida, si sarebbe impadronita di lei un’angoscia che aveva imparato a conoscere.” (p. 166) Poi quello che temeva (forse) accade: “Si era appena riseduta, stava per infilare in una calza l’uovo di legno verniciato, quando il richiamo divenne irresistibile, e lei si vestì, evitando di guardarsi allo specchio.” (p. 166) Dominique viene dunque rapita da un bisogno che la rende inquieta: un “richiamo”. Ora e per sempre perde il controllo di se stessa. Diventa letteralmente accecata. Esce nel mondo, come spinta da un demone interiore, un vero e proprio “demone meridiano” non è la prima volta [“Già una decina di volte, forse anche di più, era arrivata fin lì, con quella sua figura minuta, i nervi tesi..”p. 167), ma in questo caso si aggira senza meta come un animale. Sempre in quest’ora pomeridiana, le tre del pomeriggio, all’inizio del romanzo Dominique aveva provato un altro turbamento.
Ben diversa la situazione che si vive dalla finestra di un altro cortile, quello hitchcockiano (La finestra sul cortile). Il racconto di Cornell Woolrich da cui è tratto ha questo incipit: “Non conoscevo i loro nomi. Non avevo mai udito le loro voci. Per essere esatti, non li conoscevo neppure di vista, perché mi era impossibile, da quella distanza, distinguere bene i lineamenti dei loro volti. Eppure, avevo ricostruito l’orario dei loro movimenti, delle loro attività quotidiane. Erano tutti miei dirimpettai, dalla parte del cortile.” (“La finestra sul cortile”, in a cura di Gian Franco Orsi, Il delitto secondo Hitchcock, Milano, A. Mondadori, 1979, p. 11). La distanza (e non il distacco come in Simenon) e già qui una lontananza, esattamente l’inverso di quanto accade a Dominique. C’è bisogno allora di un mezzo artificiale, binocolo o teleobiettivo (Hitchcock) per avvicinare di più le cose. Si tratta di due visioni differenti, la prima (Simenon) strumento di compartecipazione a una vita esterna, la seconda (Woolrich-Hitchcock) strumento per una possibile detection. “Le lenti riuscivano a seguirlo fino nell’interno della casa dove fino a quel momento i miei soli occhi non avevano potuto penetrare.” (p. 36) Man mano che spunta e si modella il sospetto di un omicidio, la vista è sempre più acuta e si perfeziona (attraverso protesi come il teleobiettivo) fino a cercare con la sola vista più di quello che la vista può dare: “Dio, come osservavo la sua espressione. I miei occhi aderivano ad essa come sanguisughe. (p. 36) Descrizione che – con tutte le differenze del caso si avvicina comunque a quella simenoniana di Dominique: “fingeva di non vedere niente intorno a sé, eppure si appropriava come una ladra della vita che le scorreva accanto.” (p.167) Ma a Jeff, il personaggio hitchcockiano, interessa fino a un certo punto la vita degli altri, o almeno, dall’interesse professionale (è un fotografo) questo si traduce in una detection guidata dal sospetto che un suo dirimpettaio possa avere ucciso la moglie, il suo sguardo registra, ma seleziona, al contrario di quello di Dominique che invece accumula nutrendo la sua vita delle esistenze degli altri.
Ne La finestra sul cortile, la vista è il senso principe, e tuttavia non basta, anche lo sguardo può arrivare solo fino a un certo punto e ha bisogno di un avvicinamento artificiale. Tuttavia anche qui ci sono momenti in cui la vista viene necessariamente integrata: “A volte, i sensi captano cose senza che la mente le traduca nel loro giusto significato, I miei occhi videro quello sguardo. La mia mente rifiutò di analizzarlo come doveva.” (p. 46) Più che di sensi si tratta di intuizioni, di associazioni alimentate tuttavia dallo sguardo. Più ancora del film di Hitchcock il testo di Woolrich è rivelatore. Davanti ai suoi occhi si è svolta una scena in cui ha percepito qualcosa di stonato, qualcosa di misterioso e importante che cerca disperatamente di recuperare nella memoria, ma “La mia memoria, senza l’aiuto delle immagini, non era in grado di ricatturare quel particolare stonato.” (p. 38-9) L’occhio di Woolrich, come quello di Hitchcock domina e organizza il mondo, non per parteciparvi (come Dominique) ma per trovarvi l’errore e porvi rimedio. “L’occhio è un controllore fidato” (p. 48) dice Jeffries, e se pure questa frase così lapidaria potrebbe essere sottoscritta anche da Dominique, il senso della loro “passione” visiva è estremamente differente. In Woolrich-Hitchcock, laddove lo sguardo non arriva c’è pur sempre la protesi del cannocchiale o del teleobiettivo, per Simenon è un sopravvenire di tutti i sensi ad annebbiare la vista, ma nel momento in cui Dominique si affida all’odorato, al tatto, all’udito per muoversi, ecco che si perde, non sa controllare gli altri sensi come controlla le cose e la propria vita, o quella altrui, attraverso la vista.
Nel momento di noia, di vera e propria accidia, Jeffries si trova un’ulteriore occupazione, lega il proprio sguardo, la propria memoria e la razionalità in un unicum attraverso una detection sotterranea, nascosta. Dominique invece, vi si abbandona, segue il suo demone perdendo ogni razionalità ogni controllo, la vita di tutti i vicini appare lontana e sfilacciata e così la sua perde consistenza e definizione. Non accettando ciò che gli altri sensi le offrono (la vita) non può che fare una scelta estrema e tutto sommato, inaspettata.
In realtà il personaggio di Dominique ha molto a che vedere con altri personaggi simenoniani, o perlomeno la loro solitudine, l’ambientazione, la normalità delle loro vite, come, per esempio il signor Hire (Il fidanzamento del signor Hire) che osserva di nascosto, da dietro la finestra, la domestica Alice che si spoglia, personaggio che a sua volta è spiato. Oppure, Adil Bey, il personaggio di Le finestre di fronte, e l’intensità presente in Maigret e il fantasma. Poi la presenza di quel mondo chiuso, apparentemente rassicurante quale il cortile, sia nei libri citati, sia in altri, che torna come una costante, luogo di incontro di ciò che è familiare e di ciò che è estraneo. Uno spazio comunque attraversato, fatto proprio nonostante tutto, in cui vengono conservati inalterati quei rapporti e quelle distanze che Hitchcock, nel suo film, illustra con precisione, mantenendo i personaggi ognuno al suo posto, nel proprio appartamento, come faranno alla fine Jeffries e Lisa, che lasciamo soli, finalmente con le tende abbassate, il mondo fuori, una volta per tutte.